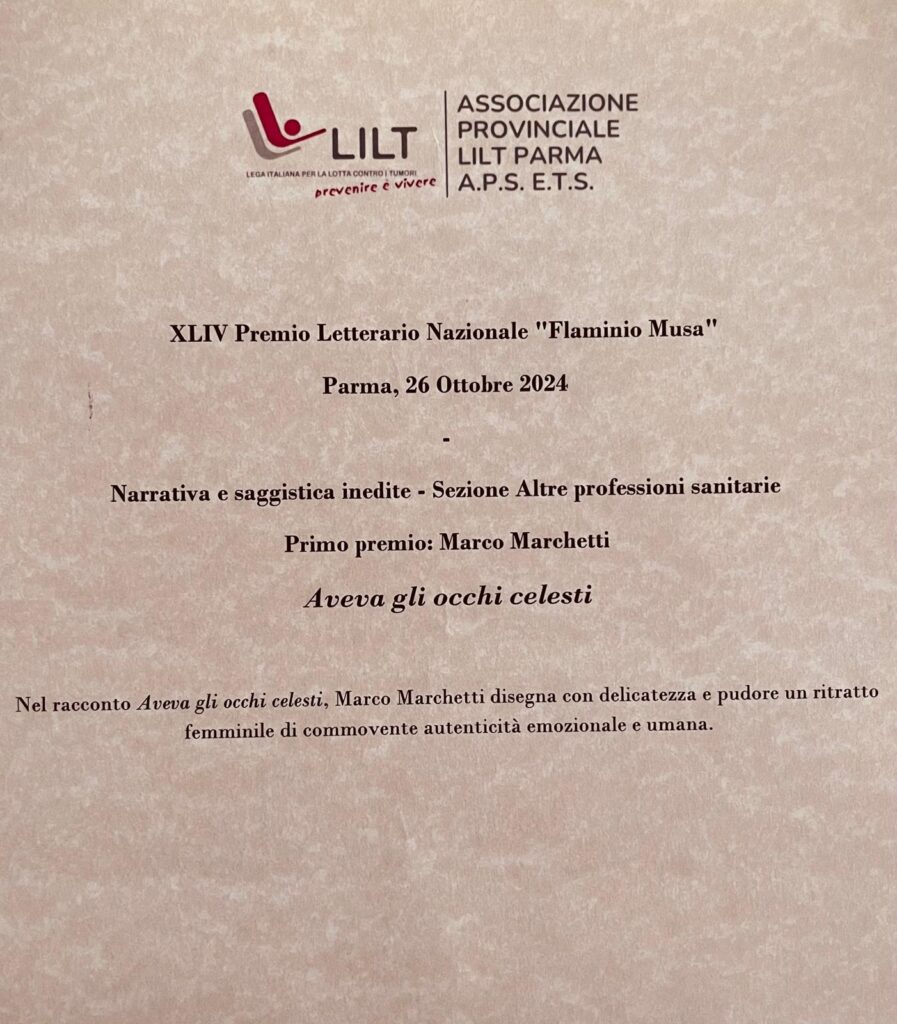La prima volta che la vidi giocavo con gli elastici ed il levafustelle.
Era un tardo pomeriggio di autunno. Il freddo iniziava a farsi pungente ma ancora non troppo fastidioso. Pioveva. Era uno di quei momenti di stanca, quando nessuno varca la soglia e la farmacia appare vuota. Uno di quei pochi attimi di relax che si ritagliano durante una giornata di lavoro.
“Ciao dottore” mi sentii dire.
Mentre alzavo gli occhi per dare un volto alla voce, pensavo alla strana coppia di parole: ciao: colloquiale, dottore: più formale. Sembrava quasi un ossimoro, suonava bene pensai. Appena alzati gli occhi incrociai il suo sguardo. Aveva gli occhi celesti. Un tempo doveva essere stata molto bella ora appariva segnata dalla vita. Poggiò le ricette sul banco e ripetè quella strana forma di saluto.
“Buonasera” risposi, “come sta”?
“Male” mi disse, “oggi proprio non je la faccio”. Si appoggiò al bancone quasi di colpo.
Cercava un sostegno, appoggiò i gomiti e il peso di quasi tutto il corpo. Mi guardò dal basso. Faceva tenerezza…
Per prendere la ricetta le carezzai la mano, Era calda, le unghie curate ma senza smalto, il segno di una flebo recente sul dorso.
Lei mi sorrise e me la strinse. Forte, con entrambe le mani.. Continuava a stringerla. Con la mano libera raccolsi le ricette dal banco.
Lessi e capii.
Doveva prendere due scatole di iniezioni, di quei farmaci che non vorresti mai dare. Uno di quei farmaci che sai di consegnare ad una persona con la vita in attesa, segnata.
“Su su” le dissi senza convinzione, erano solo convenevoli, detti quasi recitando un copione. Non si è mai pronti a parlare con chi ha un brutto male. Tutto appare scontato e privo di senso, tutto banale. Inutile ogni parola. Ti senti quasi in colpa, lo leggi negli occhi.
Invece lei mi sorprese. Quasi traendo forza dalla mia stupida risposta mi fissò con i suoi occhi intensi e mi disse: “tanto non vince. La bestiaccia non vincerà mai”.
Bestiaccia. Lei il cancro lo chiamava cosi.
Fu solo un attimo, ma bellissimo.
Vidi un lampo nei suoi occhi, vidi un lampo di vita, Vidi La Vita.
Vidi la voglia di restare tenacemente attaccata al mondo, la voglia di sorridere e camminare ancora, la voglia di parlare ad uno sconosciuto facendo la fila alla posta, la voglia di uscire in strada e farsi bagnare dalla pioggia perché ci si è dimenticati l’ombrello.
La voglia di sedersi su di una panchina in un parco a guardare rinascere la primavera. Vidi la voglia di cose comuni. Vidi la voglia di vivere.
“Come si chiama signora”?
“Luciana” rispose. “E tu”?
“Marco”.
Consegnai i farmaci e la salutai.
“Ciao Marco, ci vediamo presto”
Si voltò.
Camminava piano.
Con lo sguardo la seguii uscire. Da quel giorno fu un’abitudine.
La vedevo entrare ed aspettare il suo turno. A volte appoggiandosi ad un bastone, a volte reggendosi miracolosamente sulle sole gambe. Soffriva. Resisteva.
Era un leone.
Vidi i suoi capelli farsi sempre più fini poi più radi, incontro dopo incontro.
La vidi in inverno coperta da sciarpe e cappotto, la vidi in primavera, con una sola maglia di cotone. Blu, pesante. Sempre la stessa. Doveva avere venti anni quella maglia.
Sembrava nuova.
La vidi affannata, con le parole che uscivano a fatica. Quelli erano i giorni dopo la terapia, i giorni in cui stava peggio. Stava male ma era sempre dignitosa, sempre vigile ed attenta a tutto.
Aspettando il suo turno mi guardava e faceva l’occhiolino. Non si reggeva in piedi ma sorrideva. Avrei voluto abbracciarla.
Una volta la incontrai per caso appena uscito dalla farmacia.
“Ciao” mi disse.
“Vai a casa”?
“Si, ho appena finito”.
“Guarda cosa ti faccio vedere”.
Mi prese il braccio e si avvicinò.
Aprì la borsa.
Era una borsa di pelle scura, bella, forse di marca.
L’interno foderato di rosso.
C’erano poche cose, si vedevano bene. Cose normali, semplici. Facevano tenerezza, come lei.
C’era un mazzo di chiavi con un portachiavi tanto vecchio quanto usato. C’era una targhetta con scritto a mano: garage. La grafia era molto bella ma incerta. Tremolante.
C’era una castagna portafortuna ed un pacchetto di fazzoletti.
Non aveva borsellino. Pensai che tenesse i soldi ed i documenti in tasca. Come fanno tanti anziani seguendo la loro lucida previdenza.
Tirò fuori una foto.
La stringeva in mano con cura. Il pollice avanti per tenerla, il palmo dietro, come per accarezzare quell’immagine.
Erano due persone. Una coppia in bianco e nero. Eleganti, sorridenti.
“Sono i miei genitori” mi disse.
Erano belli nella loro posa. La donna sorrideva appoggiandosi al marito, l’uomo dava il braccio alla moglie ma guardava di lato. Sotto il borsalino aveva lo sguardo cupo, pensieroso, distante.
“L’hanno scattata pochi giorni prima che mio padre morisse”. Commentò lei…
Baciò la foto e la girò.
C’era una ragazza.
“Questa è mia figlia”. “Vive lontano, la vedo poco”. “Sai com’è, il lavoro…”
Divenne triste, raccontava della figlia, si rivolgeva a me ma in realtà parlava a se stessa.
Ripeteva sempre quella stessa storia,non convinceva gli altri, non ci credeva neanche lei.
Si sbrigò a riporre tutto. Chiuse la borsa velocemente come a voler scacciare un pensiero.
Lo chiuse con le foto, dentro la borsa.
Con due immagini aveva raccontato la sua vita.
Chissà perché certe foto parlano tanto pensai.
“Ciao” mi disse, “vai che fai tardi”.
Non facevo tardi io, era lei che si era commossa.
Non ci fu bisogno di aggiungere altro.
Si allontanò. Io rimasi fermo a guardarla.
La osservai andare via lentamente, china, poggiata sul bastone.
Pensai al lei, alla sua vita.
Aveva la foto dei genitori e della figlia, saltava una generazione. mancava il marito.
Chissà se ne aveva mai avuto uno. Mi convinsi che si, in fondo un marito doveva averlo avuto, E magari era stata lasciata. Per questo non conservava la sua foto tra le altre. Per questo era cosi forte. Forte come solo una donna abbandonata riesce ad essere.
Una donna costretta ad allevare una figlia da sola, a trovare un lavoro con cui mantenersi, a combatterete il pensiero ricorrente di un uomo traditore. Di un uomo che amava ancora, malgrado tutto, nonostante tutto.
Immaginai la sua vita passata. Le carezze alla figlia, le telefonate alla mamma.
Immaginai gli sforzi di una vita tutti incentrati a far crescere bene una bambina, farla diventare donna senza farle mancare nulla.
E poi immaginai la sua attuale solitudine.
Ripercorsi con lei le scale per tornare a casa, mi fermai con lei a rifiatare ogni pianerottolo.
Sentii la sua stessa stanchezza.
Mentalmente girai con lei la chiave nella serrature del suo appartamento.
Immaginai l’odore pungente tipico delle case delle persone anziane. Odore che sa di pranzi con il telegiornale, e cene appena fa buio. Vidi le parole crociate sul divano, e gli occhiali poggiati sopra. Una mantella di lana per proteggersi dal freddo. L’incessante ticchettio dell’orologio. Le gocce per dormire sul comodino, la Madonna appesa al muro, con il rosario che pende ed il ramo d’olivo. Il telefono che non suona mai, il calendario con i numeri grandi e tanto spazio per scrivere.
Vidi in una sola immagine la sua casa, vidi la sua quotidianità.
Vidi le medicine che io stesso le consegnavo, tutte insieme, disposte ordinate sul centrino del mobile bello in sala. E sulla sedia poco distante, vidi le buste grandi e colme di lastre, esami referti. Pronte all’ingresso. Chissà per andare dove.
Immaginai la sua vita. Mi si strinse il cuore.
Tornai al momento e la fissai.
Avrei voluto abbracciarla e farla ridere, avrei voluto regalarle una serata in compagnia, una pizza, una cena diversa dal solito.
Avrei voluto portarla via dal quel pensiero fisso con cui conviveva. Quell’avvicinarsi di una data, quella paura di soffrire.
Avrei voluto, non lo feci, ed ancora rimpiango quel momento.
Ebbi paura di sembrare invadente, ebbi pudore e rispetto del suo dolore.
Ebbi paura di un rifiuto.
Non la vidi più. A saperlo, le sarei corso dietro.
Invece non lo feci. Andò via cosi, lasciandomi a pensare al suo modo ed alle sue parole, esattamente come la prima volta che la vidi.
Pensavo al modo che aveva avuto, mi accorsi troppo tardi che stavo guardando il dito, perdendo luna che indicava.
Fu l’ultima volta che lo feci.
Ora cerco di essere meno razionale e di seguire il dito fino a farmi indicare la luna.
E guardando la luna, oggi riesco a dire tante più volte: Ti voglio bene.
Mi sforzo di dare più che ricevere e stringo forte la persone che amo abbracciandola, per farle sentire il mio calore. Il mio amore.
Per non avere più rimpianti.
Lei non c’è più ed io continuo a lavorare in farmacia e quando non c’è gente mi sorprendo a giocare ancora con gli elastici ed il levafustelle.
Ma ora non lo faccio più guardando in basso. Guardo la porta, perché, in fondo, spero di vederla arrivare nuovamente e dirmi sorridendo: “ciao dottore”…